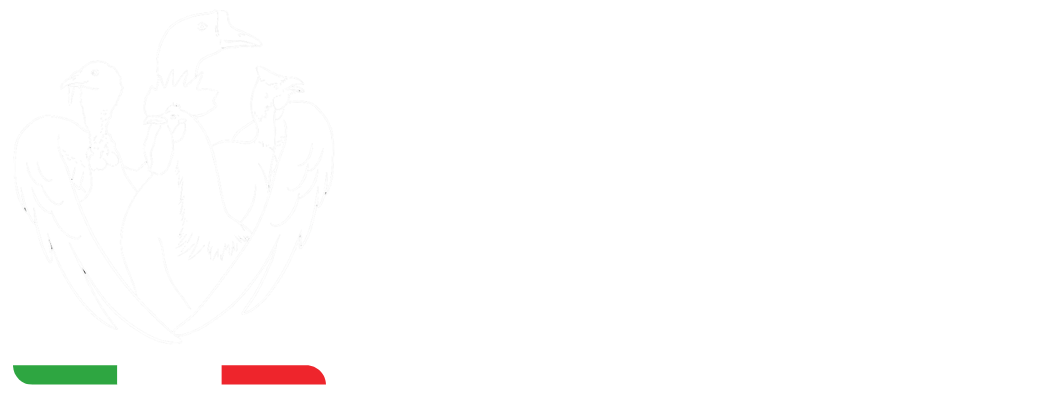Razze Avicole, espressione genica e ambiente


Come variano le generazioni dei viventi nel corso del tempo?
Il concetto di evoluzione è cambiato molte volte negli anni, e se fin dai tempi di Darwin si pensava a ogni variazione evolutiva come a una mutazione genetica ereditaria di generazione in generazione, oggi studi di embriologia e biologia evolutiva dello sviluppo suggeriscono un più “evoluto” concetto di fenotipo, risultante dall’interazione tra gene e ambiente e inteso come una variazione dell’espressione genica piuttosto che come una mutazione.
Fermo quindi che portatori di genotipi identici (cioè dotati della stessa informazione genomica già all’interno della cellula uovo) possono manifestare differenti fenotipi (ovvero diverse espressioni geniche nei singoli individui adulti), dagli anni ’90 del Novecento la comunità scientifica esprime un parere concorde nel ritenere che l’evoluzione (dal latino evolvĕre, “cambiare rispetto a prima”) sia influenzata da interazioni e modifiche ambientali, nella misura in cui l’ambiente riesce a stimolare e/o regolare l’espressione genica.
Si parla quindi di plasticità, ovvero dell’azione dell’ambiente sul fenotipo di un organismo, e di **epigenetica ambientale**, che riguarda invece l’azione dell’ambiente sui meccanismi molecolari.
Per intenderci, queste influenze sulla variazione dell’espressione genica possono portare, ad esempio, alla produzione di proteine incomplete o analoghe, determinando fenotipi diversi che potrebbero definire nuove linee evolutive, a seconda delle condizioni ambientali in cui l’individuo si trova.
In alcuni organismi animali, e talvolta in modo evidente anche nei polli, possono verificarsi variazioni nella forma del corpo. Una simile plasticità, dipendente da stimoli esterni, potrebbe scaturire dalla morte di un maschio dominante o dall’assenza di maschi in un gruppo, creando squilibri sociali. In questi casi, la femmina alfa (prima nella gerarchia dell’”ordine di beccata”) potrebbe assumere il ruolo del gallo, sviluppando una muscolatura più robusta e, in casi estremi, caratteri secondari maschili come speroni, cresta più grande e maggiore aggressività. Questa trasformazione deriverebbe da una sovrastimolazione di geni regolatori degli ormoni, innescando una plasticità reversibile che “mascolinizza” la femmina.
Le risposte plastiche si classificano in adattative/non adattative, specifiche/generali e reversibili/non reversibili. Ad esempio, un irrobustimento muscolare come risposta adattativa potrebbe verificarsi in animali che necessitano di fuggire più velocemente dai predatori, sviluppando ali più lunghe.
Un altro esempio è il dimorfismo sessuale (dal greco “due forme”), dove maschi e femmine presentano caratteristiche diverse. Spesso i maschi sono più grandi e aggressivi per proteggere il gruppo, mentre in alcune specie (come i falconiformi) le femmine sono più grandi per ridurre la competizione alimentare.
Galliformi, anatidi e fasianidi mostrano dimorfismi cromatici, dimensionali e comportamentali. In Italia, la varietà di ambienti rurali e climi ha favorito un’enorme diversità genetica, influenzata da fattori morfologici, ecologici e culturali. Le razze locali, adattate a contesti specifici, sono spesso più resilienti rispetto alle varietà moderne.
Ogni razza racconta una storia di adattamenti, dal piumaggio alla deposizione delle uova, con implicazioni culturali, socioeconomiche ed ecologiche. Studi genetici hanno identificato geni legati all’immunità (PLA2G7, ENPP4), al gusto amaro (utile per evitare tossine), all’adattamento al caldo (FGF14, NALCN), alla crescita (METTL21C) e allo sviluppo muscolare (CREBL2 nell’anatra).
Questa conoscenza è fondamentale per programmi di conservazione delle razze autoctone, il cui merito va agli allevatori custodi, associazioni e appassionati che promuovono tutela, gestione sostenibile e collaborazione.
a cura di Vincenzo Lauro – Biologo ricercatore